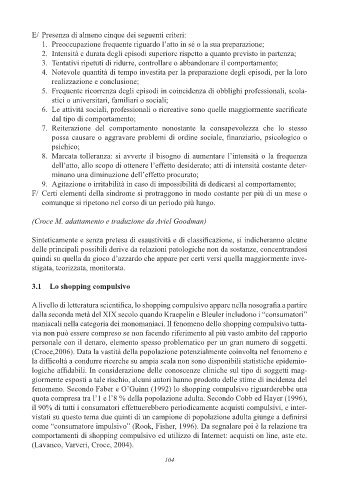Page 104 - Sipsot Libro Linee di Indirizzo_27_aprile
P. 104
E/ Presenza di almeno cinque dei seguenti criteri:
1. Preoccupazione frequente riguardo l’atto in sé o la sua preparazione;
2. Intensità e durata degli episodi superiore rispetto a quanto previsto in partenza;
3. Tentativi ripetuti di ridurre, controllare o abbandonare il comportamento;
4. Notevole quantità di tempo investita per la preparazione degli episodi, per la loro
realizzazione e conclusione;
5. Frequente ricorrenza degli episodi in coincidenza di obblighi professionali, scola-
stici o universitari, familiari o sociali;
6. Le attività sociali, professionali o ricreative sono quelle maggiormente sacrificate
dal tipo di comportamento;
7. Reiterazione del comportamento nonostante la consapevolezza che lo stesso
possa causare o aggravare problemi di ordine sociale, finanziario, psicologico o
psichico;
8. Marcata tolleranza: si avverte il bisogno di aumentare l’intensità o la frequenza
dell’atto, allo scopo di ottenere l’effetto desiderato; atti di intensità costante deter-
minano una diminuzione dell’effetto procurato;
9. Agitazione o irritabilità in caso di impossibilità di dedicarsi al comportamento;
F/ Certi elementi della sindrome si protraggono in modo costante per più di un mese o
comunque si ripetono nel corso di un periodo più lungo.
(Croce M. adattamento e traduzione da Aviel Goodman)
Sinteticamente e senza pretesa di esaustività e di classificazione, si indicheranno alcune
delle principali possibili derive da relazioni patologiche non da sostanze, concentrandosi
quindi su quella da gioco d’azzardo che appare per certi versi quella maggiormente inve-
stigata, teorizzata, monitorata.
3.1 Lo shopping compulsivo
A livello di letteratura scientifica, lo shopping compulsivo appare nella nosografia a partire
dalla seconda metà del XIX secolo quando Kraepelin e Bleuler includono i “consumatori”
maniacali nella categoria dei monomaniaci. Il fenomeno dello shopping compulsivo tutta-
via non può essere compreso se non facendo riferimento al più vasto ambito del rapporto
personale con il denaro, elemento spesso problematico per un gran numero di soggetti.
(Croce,2006). Data la vastità della popolazione potenzialmente coinvolta nel fenomeno e
la difficoltà a condurre ricerche su ampia scala non sono disponibili statistiche epidemio-
logiche affidabili. In considerazione delle conoscenze cliniche sul tipo di soggetti mag-
giormente esposti a tale rischio, alcuni autori hanno prodotto delle stime di incidenza del
fenomeno. Secondo Faber e O’Guinn (1992) lo shopping compulsivo riguarderebbe una
quota compresa tra l’1 e l’8 % della popolazione adulta. Secondo Cobb ed Hayer (1996),
il 90% di tutti i consumatori effettuerebbero periodicamente acquisti compulsivi, e inter-
vistati su questo tema due quinti di un campione di popolazione adulta giunge a definirsi
come “consumatore impulsivo” (Rook, Fisher, 1996). Da segnalare poi è la relazione tra
comportamenti di shopping compulsivo ed utilizzo di Internet: acquisti on line, aste etc.
(Lavanco, Varveri, Croce, 2004).
104