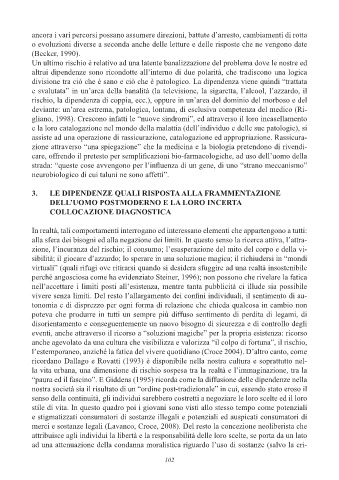Page 102 - Sipsot Libro Linee di Indirizzo_27_aprile
P. 102
ancora i vari percorsi possano assumere direzioni, battute d’arresto, cambiamenti di rotta
o evoluzioni diverse a seconda anche delle letture e delle risposte che ne vengono date
(Becker, 1990).
Un ultimo rischio è relativo ad una latente banalizzazione del problema dove le nostre ed
altrui dipendenze sono ricondotte all’interno di due polarità, che tradiscono una logica
divisione tra ciò che è sano e ciò che è patologico. La dipendenza viene quindi “trattata
e svalutata” in un’area della banalità (la televisione, la sigaretta, l’alcool, l’azzardo, il
rischio, la dipendenza di coppia, ecc.), oppure in un’area del dominio del morboso e del
deviante: un’area estrema, patologica, lontana, di esclusiva competenza del medico (Ri-
gliano, 1998). Crescono infatti le “nuove sindromi”, ed attraverso il loro incasellamento
e la loro catalogazione nel mondo della malattia (dell’individuo e delle sue patologie), si
assiste ad una operazione di rassicurazione, catalogazione ed appropriazione. Rassicura-
zione attraverso “una spiegazione” che la medicina e la biologia pretendono di rivendi-
care, offrendo il pretesto per semplificazioni bio-farmacologiche, ad uso dell’uomo della
strada: “queste cose avvengono per l’influenza di un gene, di uno “strano meccanismo”
neurobiologico di cui taluni ne sono affetti”.
3. LE DIPENDENZE QUALI RISPOSTA ALLA FRAMMENTAZIONE
DELL’UOMO POSTMODERNO E LA LORO INCERTA
COLLOCAZIONE DIAGNOSTICA
In realtà, tali comportamenti interrogano ed interessano elementi che appartengono a tutti:
alla sfera dei bisogni ed alla negazione dei limiti. In questo senso la ricerca attiva, l’attra-
zione, l’incuranza del rischio; il consumo; l’esasperazione del mito del corpo e della vi-
sibilità; il giocare d’azzardo; lo sperare in una soluzione magica; il richiudersi in “mondi
virtuali” (quali rifugi ove ritirarsi quando si desidera sfuggire ad una realtà insostenibile
perché angosciosa come ha evidenziato Steiner, 1996); non possono che rivelare la fatica
nell’accettare i limiti posti all’esistenza, mentre tanta pubblicità ci illude sia possibile
vivere senza limiti. Del resto l’allargamento dei confini individuali, il sentimento di au-
tonomia e di disprezzo per ogni forma di relazione che chieda qualcosa in cambio non
poteva che produrre in tutti un sempre più diffuso sentimento di perdita di legami, di
disorientamento e conseguentemente un nuovo bisogno di sicurezza e di controllo degli
eventi, anche attraverso il ricorso a “soluzioni magiche” per la propria esistenza: ricorso
anche agevolato da una cultura che visibilizza e valorizza “il colpo di fortuna”, il rischio,
l’estemporaneo, anziché la fatica del vivere quotidiano (Croce 2004). D’altro canto, come
ricordano Dallago e Rovatti (1993) è disponibile nella nostra cultura e soprattutto nel-
la vita urbana, una dimensione di rischio sospesa tra la realtà e l’immaginazione, tra la
“paura ed il fascino”. E Giddens (1995) ricorda come la diffusione delle dipendenze nella
nostra società sia il risultato di un “ordine post-tradizionale” in cui, essendo stato eroso il
senso della continuità, gli individui sarebbero costretti a negoziare le loro scelte ed il loro
stile di vita. In questo quadro poi i giovani sono visti allo stesso tempo come potenziali
e stigmatizzati consumatori di sostanze illegali e potenziali ed auspicati consumatori di
merci e sostanze legali (Lavanco, Croce, 2008). Del resto la concezione neoliberista che
attribuisce agli individui la libertà e la responsabilità delle loro scelte, se porta da un lato
ad una attenuazione della condanna moralistica riguardo l’uso di sostanze (salvo la cri-
102