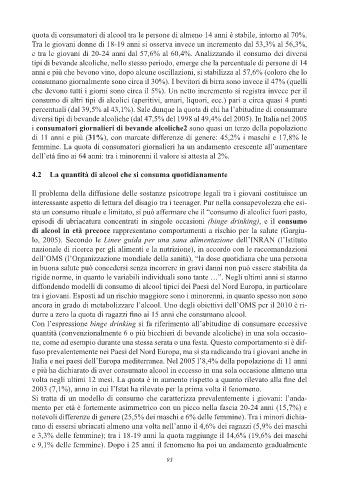Page 93 - Sipsot Libro Linee di Indirizzo_27_aprile
P. 93
quota di consumatori di alcool tra le persone di almeno 14 anni è stabile, intorno al 70%.
Tra le giovani donne di 18-19 anni si osserva invece un incremento dal 53,3% al 56,3%,
e tra le giovani di 20-24 anni dal 57,6% al 60,4%. Analizzando il consumo dei diversi
tipi di bevande alcoliche, nello stesso periodo, emerge che la percentuale di persone di 14
anni e più che bevono vino, dopo alcune oscillazioni, si stabilizza al 57,6% (coloro che lo
consumano giornalmente sono circa il 30%). I bevitori di birra sono invece il 47% (quelli
che devono tutti i giorni sono circa il 5%). Un netto incremento si registra invece per il
consumo di altri tipi di alcolici (aperitivi, amari, liquori, ecc.) pari a circa quasi 4 punti
percentuali (dal 39,5% al 43,1%). Sale dunque la quota di chi ha l’abitudine di consumare
diversi tipi di bevande alcoliche (dal 47,5% del 1998 al 49,4% del 2005). In Italia nel 2005
i consumatori giornalieri di bevande alcoliche2 sono quasi un terzo della popolazione
di 11 anni e più (31%), con marcate differenze di genere: 45,2% i maschi e 17,8% le
femmine. La quota di consumatori giornalieri ha un andamento crescente all’aumentare
dell’età fino ai 64 anni: tra i minorenni il valore si attesta al 2%.
4.2 La quantità di alcool che si consuma quotidianamente
Il problema della diffusione delle sostanze psicotrope legali tra i giovani costituisce un
interessante aspetto di lettura del disagio tra i teenager. Pur nella consapevolezza che esi-
sta un consumo rituale e limitato, si può affermare che il “consumo di alcolici fuori pasto,
episodi di ubriacatura concentrati in singole occasioni (binge drinking), e il consumo
di alcool in età precoce rappresentano comportamenti a rischio per la salute (Gargiu-
lo, 2005). Secondo le Linee guida per una sana alimentazione dell’INRAN (l’Istituto
nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione), in accordo con le raccomandazioni
dell’OMS (l’Organizzazione mondiale della sanità), “la dose quotidiana che una persona
in buona salute può concedersi senza incorrere in gravi danni non può essere stabilita da
rigide norme, in quanto le variabili individuali sono tante …”. Negli ultimi anni si stanno
diffondendo modelli di consumo di alcool tipici dei Paesi del Nord Europa, in particolare
tra i giovani. Esposti ad un rischio maggiore sono i minorenni, in quanto spesso non sono
ancora in grado di metabolizzare l’alcool. Uno degli obiettivi dell’OMS per il 2010 è ri-
durre a zero la quota di ragazzi fino ai 15 anni che consumano alcool.
Con l’espressione binge drinking si fa riferimento all’abitudine di consumare eccessive
quantità (convenzionalmente 6 o più bicchieri di bevande alcoliche) in una sola occasio-
ne, come ad esempio durante una stessa serata o una festa. Questo comportamento si è dif-
fuso prevalentemente nei Paesi del Nord Europa, ma si sta radicando tra i giovani anche in
Italia e nei paesi dell’Europa mediterranea. Nel 2005 l’8,4% della popolazione di 11 anni
e più ha dichiarato di aver consumato alcool in eccesso in una sola occasione almeno una
volta negli ultimi 12 mesi. La quota è in aumento rispetto a quanto rilevato alla fine del
2003 (7,1%), anno in cui l’Istat ha rilevato per la prima volta il fenomeno.
Si tratta di un modello di consumo che caratterizza prevalentemente i giovani: l’anda-
mento per età è fortemente asimmetrico con un picco nella fascia 20-24 anni (15,7%) e
notevoli differenze di genere (25,5% dei maschi e 6% delle femmine). Tra i minori dichia-
rano di essersi ubriacati almeno una volta nell’anno il 4,6% dei ragazzi (5,9% dei maschi
e 3,3% delle femmine); tra i 18-19 anni la quota raggiunge il 14,6% (19,6% dei maschi
e 9,1% delle femmine). Dopo i 25 anni il fenomeno ha poi un andamento gradualmente
3